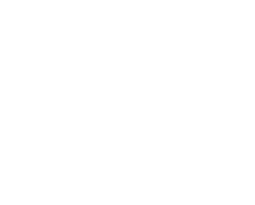IL CUORE VUOTO DELLA COMUNITA’ CRISTIANA, di Andrea Ponso
PECCATO E PERDONO COME FONDAMENTO DEL NASCERE
di Andrea Ponso*
sull’ultimo libro di Paolo Farinella, Peccato e perdono. Un capovolgimento di prospettiva (Collana ESH, Gabrielli editori)
 Questo libro di Paolo Farinella, come molti dei suoi lavori, si inserisce polemicamente all’interno dei luoghi comuni sul peccato e sul perdono, rischiando a volte anche visioni troppo unilaterali, ma sempre in funzione di una positiva scossa delle coscienze comodamente addormentate: coscienze dei credenti laici, e coscienze degli apparati ecclesiastici, in una sorta di patto che, in fondo, spesso fa comodo ad entrambi perché evita lo scontro con la complessità dell’umano e del divino. Ma è proprio nel recupero di questa complessità che questo saggio, a mio avviso, trova il suo equilibrio e il suo punto di forza.
Questo libro di Paolo Farinella, come molti dei suoi lavori, si inserisce polemicamente all’interno dei luoghi comuni sul peccato e sul perdono, rischiando a volte anche visioni troppo unilaterali, ma sempre in funzione di una positiva scossa delle coscienze comodamente addormentate: coscienze dei credenti laici, e coscienze degli apparati ecclesiastici, in una sorta di patto che, in fondo, spesso fa comodo ad entrambi perché evita lo scontro con la complessità dell’umano e del divino. Ma è proprio nel recupero di questa complessità che questo saggio, a mio avviso, trova il suo equilibrio e il suo punto di forza.
Trattando del peccato, Farinella parte subito dal nodo del “peccato originale”. Egli giustamente sostiene che la lettura del peccato originale, che si regge su una interpretazione esegeticamente sbagliata di alcuni passi biblici – e ancora su di una idea filogenetica che partirebbe dagli unici progenitori iniziali, come tentativo di “far quadrare il cerchio” delle costruzioni concettuali, e solo concettuali, della teologia – diventa un meccanismo perverso di tipo economico, legato al dare e avere burocratico. Da un lato del mercato il credente con i suoi peccati, ontologicamente da sempre presenti grazie al peccato originale – e dall’altro il venditore che è la chiesa, come distributrice di pratiche per alleviarne le pene e “guadagnare” la salvezza. Questo “schema perfetto con le caselle al loro posto”, per tranquillizzare le coscienze, come ci dice l’autore, è praticamente il contrario della ricerca e della dinamica della fede:
L’ipotesi del peccato originale si regge su una lettura storico-cronologica che porta con sé la conseguenza che prima c’è (ci deve essere per necessità) il peccato di Adam ed Eva e poi, solo successivamente, la venuta e la redenzione di Gesù, mandato dal Padre a chiamare l’umanità smarrita e a restaurare il danno compiuto dai progenitori. […] Se per necessità Adam è “prima” di Cristo e il peccato era necessario (necessità teologica) alla redenzione, non c’è colpa o responsabilità nella loro scelta, per cui ci troviamo di fronte a un rebus che prima o poi bisogna risolvere. La necessità teologica, che qui può anche definirsi come ontologica, esclude tassativamente la libertà, cioè la possibilità di scelta. Se tutto era “predestinato”, Adam ed Eva, come Giuda, hanno fatto solo il loro dovere. Se, infatti, essi avessero avuto la possibilità del libero arbitrio e avessero scelto in senso contrario a quello che hanno fatto, avrebbero imposto il fallimento al “disegno di Dio” e sant’Agostino invocherebbe ancora la necessità del peccato di Adam e l’umanità non avrebbe conosciuto Gesù Cristo.
La logica conclusione di questo ragionamento è la seguente:
Quello che la teologia tradizionale cattolica definisce come “peccato originale” non è altro che la descrizione della relazione che ogni individuo può instaurare con Dio, non in forza della necessità di rapportarsi per l’incontro, ma in vista del possesso e del potere in sé. […] Questo è il “peccato originale”: presumere di essere all’altezza di poter conoscere il bene e il male “nella nostra assoluta autonomia, lontani da ogni relazione e dialogo con Dio e con gli altri uomini”. Quando la libertà è vissuta come potenza per imporsi come sé e consumarsi entro i confini angusti del proprio sé, si scopre l’abisso del peccato come vuoto di sé […]
Tutto questo ci porta, come perfettamente sottolinea l’autore, a non fermarci ad un tipo di interpretazione legata solamente alle logiche di un riduzionismo razionalistico e letterale delle Scritture, proprio perché il cristianesimo è parola che si fa carne e storia non riducibile a concetti o a regole morali. In questo senso mi pare fondamentale la citazione da Gv 1, 18: “Dio nessuno l’ha mai visto, il Figlio lo ha rivelato [ in greco exeghèsato]”. Il termine greco ci riporta ad un tipo di esegesi che non si ferma alla “parola” e ai concetti, ma si apre all’esegesi della vita di Cristo, ad una lettura che non può non prendere in considerazione le azioni, i gesti, gli sguardi, il patire e il gioire della carne storica dell’uomo Gesù, come immagine e realizzazione di Dio. Ogni riduzione al legalismo, all’ideologia e alla morale, vengono quindi ampliate attraverso la complessità storica e vivente; una complessità che ridona anche a noi uomini la stessa dignità e lo stesso abbraccio inclusivo. Ed è proprio da questo che si deve partire anche per un’analisi corretta del peccato e del perdono – se non vogliamo ridurre e semplificare l’uomo e Dio a quello che non sono.
Il saggio prosegue analizzando anche a livello linguistico i significati di “peccato” nell’ebraico biblico e nel greco dei vangeli, togliendo allo stesso quelle riduzioni moralistiche che, purtroppo, ancora oggi tanto peso hanno nella mente dei cristiani. Il peccato diventa allora non tanto e non solo la trasgressione a una serie di regole, quanto, piuttosto, un misconoscimento prima di tutto esistenziale-antropologico della fondamentale e costitutiva relazionalità della vita, la rottura della relazione con Dio e con gli altri, la chiusura all’essere-in-comune.
La prospettiva antropologico-esistenziale di tipo comunitario diventa ancora più pregnante e decisiva quando l’autore analizza la pratica del perdono e della conversione. La conversione rischia sempre di essere intesa come la “modifica morale del proprio comportamento per adeguarsi ai dettami della Legge di Dio”. Giustamente Farinella ci ricorda che il verbo greco è
metanoèō che riguarda la noûs, cioè il pensiero/la mentalità. Gesù si appella non alla modifica del comportamento, ma al ribaltamento dei criteri di valutazione delle scelte: cambiare modo di vedere/di valutare/di giudicare”, oppure più chiaramente “cambiate il vostro modo di pensare Dio”.
Si tratta di una prospettiva fondamentale, proprio nel senso della profondità del cambiamento, che deve davvero mettere in discussione i presupposti, magari nascosti anche a noi stessi, della nostra visione del mondo e degli altri, Dio compreso; ed è solo dal lavoro critico continuo su questo fondamento, su questo che è sempre un pre-giudizio, che si può poi raggiungere la giustezza/giustizia delle azioni e l’armonia con la legge. Inoltre, questo s-fondamento, come la stessa conversione, non è mai acquisito una volta per tutte: esso è continuo, è un cammino di conversione in cui ad ogni passo la stessa sicurezza di averlo raggiunto può tramutarsi in ostacolo e in peccato. Da questa prospettiva, allora, come ricorda Farinella, è importante allacciare la conversione con la gratuità della grazia e della misericordia, nel loro etimo biblico ed evangelico:
Misericordia e bontà, biblicamente, non sono sentimenti passeggeri o morali ma, facendo riferimento al grembo/utero materno, mettono in evidenza la natura di Dio e, nel NT, svelano che Gesù è la rivelazione della misericordia di Dio, non come sentimento passeggero, ma come anticipo della vita che donerà con la sua morte. Quando si è afferrati dalla misericordia di Dio, si scoppia di vita da traboccarne e la persona, come donna partoriente, zampilla la vita con la vita di un altro (figlio). È questo lo scandalo del Dio di Gesù Cristo: la compassione/misericordia di Dio fa rinascere a nuova vita.
Quando invece i nostri atti e le nostre azioni, seppure buoni, non diventano generatori di vita e, soprattutto, non traboccano, non escono incontro all’altro – essi, propriamente, non ex-sistono, muoiono nella loro perfezione asettica e sterile, edificando l’idolo della morale e di noi stessi, della nostra “bontà”. Ma una “bontà” che non sia generazione e nascita dell’altro e nell’altro, non è nient’altro che un ventre sterile – magari pulito, perfetto, immacolato … ma incapace di dare vita. Questa mancanza di generazione, questa incapacità di lasciar nascere l’altro tramite la misericordia/utero nell’atto di generare, diventa a volte qualcosa di ben peggiore: il rifiuto dell’autonomia e della libertà dell’altro. Inglobandolo infatti nelle spire del proprio “bene” e della propria morale ipostatizzati, l’altro non può essere libero di nascere davvero e di sperimentare la libertà e l’autonomia di una vera relazione – perché, come ci ricorda Farinella, “il perdono di Dio è al contempo la forza e la tenerezza che tesse la vita di chi ama, per proiettarlo verso la vita piena e autonoma”. Il bene ridotto a morale, insomma, può diventare un peccato grande, quando abortisce con la sua forza costrittiva e non amorosa e libera il nascere dell’altro.
Questa modalità autenticamente biblica e cristiana di concepire il perdono e la misericordia apre anche la via, contro ogni semplificazione moralistica, alla comprensione dell’infinita complessità dell’umano, con la sua forza e la sua debolezza. Scrive Farinella:
Sembra che l’autore della prima lettera di giovanni ci tenga a mettere in guardia dal vedere Dio come un assetato di vendetta, consapevole che le persone sono “umane” e quindi fallibili e quindi fragili; la vita, infatti, non procede sempre come se fosse una linea retta, ma spesso si attorciglia, torna indietro, devia, scende in basso, va in alto: la psicologia degli uomini e delle donne non è semplice, ma molto più complessa di quanto possa apparire, per questo l’autore della lettera saggiamente ci avverte e ci consola: “Qualunque cosa ci rimproveri, Dio è più grande del nostro cuore” (1Gv 3, 20). “Dio è più grande”. In queste parole vi è tutta la bellezza del cristianesimo e la tenerezza di Dio: lui è grande e non si ferma davanti alle piccineria degli esseri umani, come invece questi spesso fanno. […] L’obiettivo della conversione non è la perfezione morale, ma il compimento del proprio essere, il tentativo di raggiungere le profondità del proprio cuore e riconoscere chi si è e dove si è. Abituarsi al cambiamento! Ecco il vero senso della conversione, che in ebraico si chiama teshuvàh, termine che deriva dal verbo shûb che ha in sé l’idea del ritorno sui propri passi e si riferisce all’idea di ritornare sempre al proprio “principio”, là dove si prende coscienza di essere “immagine e somiglianza” di Dio.
In questo senso, allora, il perdono è anche guarigione; si tratta infatti di “guarire” da ogni cosa che ostacoli la pienezza della vita: “Perdonare significa togliere gli ostacoli che si frappongono alla pienezza dell’esistenza, perché solo in un’umanità degna di questo nome ognuno può incontrare gli altri e l’Altro”. Tuttavia, si può forse aggiungere che questa nuova nascita, questa novità e libertà, non fa paura solamente agli “altri” e ai rappresentanti del potere e della religione: spesso fa paura a noi per primi. Il potere a cui siamo sottomessi è infatti quasi sempre il potere a cui ci sottomettiamo: siamo noi parte di quel potere e di quella chiusura difensiva al nuovo e al presente del nascere continuo; non c’è mai, mi pare, una così netta distinzione tra il sistema e il singolo. È troppo facile e moralistico sostenere una tale dicotomia, e rischia di diventare difensivo quanto il potere stesso rifugiarsi, seppure in contrapposizione, all’ombra del potere. Sarebbe, inoltre il misconoscimento del carattere comunitario del perdono:
Un’ascesi individualista non ha senso in un contesto cristiano perché la vittoria sul peccato e sul male non è solo quella su di sé, ma anche e congiuntamente quella sul peccato e sul male degli altri. La Chiesa è una comunità in cammino che ha sempre bisogno di purificazione e di rinnovamento nel perdono dato e accolto. La sua “indole escatologica” la porta ad essere “peregrinante” nel cuore della storia con la funzione, anzi, la missione di “cirenea” dell’umanità e delle sue fragilità. In sintonia con il suo Maestro, essa, la Chiesa, “solleva/prende su di sé il peccato del mondo” (Gv 1, 29), a differenza degli specialisti della religione (dottori della Legge) che caricano gli uomini di pesi insopportabili che essi non toccano nemmeno con un dito (Lc 11, 46).
Il perdono diventa allora un vero e proprio sistema dinamico che fonda la stessa comunità cristiana, non qualcosa che si aggiunge ad essa, ma proprio il suo fondamento: “il tema centrale di Mt 18 è sicuramente il “perdono”, ed è molto significativo costituisca il perno del discorso ecclesiale, da cui rileviamo che non è una concessione o un momento, ma piuttosto un “sistema”, cioè un metodo permanente di essere cristiani”.
Questa comunità, sempre seguendo il discorso ecclesiale di Mt 18, ci dice anche la radicalità veramente sconvolgente e scandalizzante per il tempo di Gesù e anche per il nostro, come puntualizza Farinella, mettendo al suo centro i “piccoli” – vale a dire tutte le esistenze che non avevano alcun valore agli occhi della società e del modo di pensare corrente, sia di tipo legale che religioso, potremmo dire: erano un “nulla”, una “insignificanza”. Ma proprio dal cuore vuoto ma vivissimo di questi “piccoli” la comunità è chiamata all’ascolto e, con l’ascolto e la preghiera, alla sua stessa fondazione intorno a questo vuoto, a questi “piccoli”. E questi “piccoli” sono anche i peccatori, gli stranieri, i diversi, coloro che non trovano una classificazione all’interno delle regole vigenti – di contro ai detentori delle verità.
Una comunità così fondata, che non “scandalizza” ma invece accoglie e ascolta questi “piccoli”, è una comunità veramente cristiana che, al suo cuore, non può avere nessun “peso” e nessuna forza di gravità che non sia quest’apertura in-fondata nell’ascolto dell’altro che diventa anche l’Altro divino e incarnato nel prossimo. Sono proprio i “piccoli” e i “peccatori”, quelli che dalla prospettiva di chi si crede padrone della verità e della stessa comunità cristiana sono considerati tali, a fondare veramente l’ekklesìa: sono le nostre fragilità e “piccolezze”, la nostra stessa finitezza, il fondamento che Cristo abbraccia e salva, invitandoci a fare altrettanto, a mettere queste radici di “nulla”, quest’infinito vuoto, come radice. E questo è davvero sconvolgente: questo è il vero “scandalo” dell’ascolto che ci ostiniamo a non voler ascoltare mai fino in fondo. Farinella fa anche un passo ulteriore, ricordando la regola di Dt 19, 15 dove si dice che la “testimonianza” non poteva avvenire senza la presenza di due o tre persone. Questa “testimonianza”, che in Mt 18, 20 è assimilata all’efficacia della preghiera, si apre anche e soprattutto nei confronti dei “piccoli”:
è la novità cristiana che il discorso ecclesiale mette in evidenza: pregare per Mt non significa riunirsi per gratificarsi in un clima di estasi e formule e mantra e trance, ma farsi carico della fragilità altrui per presentarla a Dio nella santa assemblea orante, affinché lo Spirito di Dio sappia, a modo suo, illuminare il cuore del peccatore. Pregare significa essere presente, contemporaneo e compagno di viaggio anche di chi se n’è andato per i fatti suoi e ha voluto rompere tutti i ponti dietro a lui. Anche di fronte alla scomunica, che è la pena più grave perché rompe ogni relazione, la Chiesa non perde la speranza della conversione del peccatore e per questo chiama a testimoni “due o tre” perché diano valore formale alla preghiera, che diventa così la condizione permanente della Chiesa che non si rassegna a perdere un solo figlio. Il cristiano non ha nemici e non rompe con nessuno perché si fa “prossimo” a tutti. Mt inserendo in questo contesto il detto sulla preghiera, ci insegna che essa è il luogo privilegiato dove si sconfigge il peccato, perché ci si immerge nella natura di Dio per scoprire la nostra natura ecclesiale (cf Giac 5, 15-16; Mt 6, 12)
Farinella approfondisce poi quei casi in cui il perdono e la vendetta ci si parano davanti quando siamo vittime di delitti e violenze estreme. L’autore ne mostra la complessità e, soprattutto, quello che dovrebbero e potrebbero essere – alla luce di Cristo e del suo perdono contro chi l’ha messo in croce. In questo senso, “il perdono non esime dalla giustizia che deve affermare l’ordine della verità, anzi la priorità della verità: deve cioè poter distinguere tra vittima e carnefice”. Per questo “il perdono si colloca sull’altipiano della disumanità, perché chi perdona sa che il male fatto resta pesante con conseguenze logiche sia per chi subisce sia per chi ne è stato l’autore. Nulla potrà mai più essere come prima”. L’esempio di Cristo sulla croce si colloca proprio al centro di questa complessità “disumana”:
Gesù non si limita a perdonare da parte sua, per quanto gli compete ed è di sua pertinenza; egli va oltre: svuota di ogni resposabilità l’azione criminosa, attribuendola non all’intenzione degli autori, ma alla “assenza” di essa. I carnefici, infatti, “non sanno quello che fanno”; Gesù in sostanza, dice che nessun crimine è logico e consapevole, ma c’è sempre qualcosa o la mancanza di qualcosa che determina l’incapacità di intendere e di volere. In questo modo apre una prospettiva agli assassini, una via di riflessione finalizzata alla presa di coscienza per un cambiamento radicale che inizia sempre con un atto di conoscenza e di consapevolezza. […] Chi perdona è convinto, per motivazioni spirituali, di compiere un atto di giustizia, la sola che possa riportare l’equilibrio della verità infranta. Egli, infatti, si dispone, con l’atto supremo di perdono, ad assumere su di sé le conseguenze del male operato dagli altri, liberando l’assassino stesso o il colpevole diretto del delitto non della responsabilità di quanto ha compiuto (non sarebbe possibile nemmeno a Dio), ma delle conseguenze della vendetta e della violenza. […] Il perdono, che apparentemente sarebbe irrazionale, mantiene i rapporti di giustizia e non inquina la realtà, ma fissa i paletti della responsabilità, agendo non sui comportamenti, ma sul cuore, non sulla ragione, ma sulle ragioni “superiori” che la ragione da sola non riesce a motivare. […] Il perdono succhia il midollo della violenza e lascia il violento disarmato, con la possibilità di “vedere” il male fatto, di prenderne coscienza e, se vuole, come spesso accade, di impegnare la propria vita in una direzione opposta, quasi una ricostruzione di quanto è stato violato e distrutto. Chi, d’altra parte, sa ricevere il perdono, accogliendolo, anche se criminale, anche se assassino, anche se imperdonabile, vede la “sua” vita misurata da ciò che è stato e la proietta nel futuro, come nuova sorgente d’impegno e responsabilità.
Perdonare, paradossalmente, significa inchiodare se stessi alla croce della verità e il responsabile alle proprie responsabilità, impedendo che la vendetta e le conseguenze del male si estendano a macchia d’olio oltre il confine di quanto accaduto. Perdonare, in questo senso, è opporre al male, che si crede invincibile, una forza disarmante non violenta che è ancora più forte, perché vi oppone la diga dell’amore che travolge la violenza e la trasforma in energia di vita.
Anche nelle parole che seguono sentiamo in profondità quale sia il motore e il cuore della comunità che si forma e continua a nascere – ed è la logica del dono, di una gratuità che impegna liberamente e che non cancella contraddizioni e complessità:
Gesù libera il perdono da ogni condizionamento sociale e morale per farne solo il segno sacramentale della nuova economia di salvezza: il perdono dato agli altri è il prolungamento del perdono ricevuto. Chi è stato perdonato non può non perdonare.
Questa reciprocità, questa catena capace di fondare una comunità basata sul perdono ci viene mostrata nell’integrazione delle due versioni del Padre Nostro di Mt e di Lc:
La versione di Mt pone il perdono reciproco come condizione per ottenere il perdono di Dio: “rimetti a noi […] come noi […]”; Lc invece pone il perdono di Dio come forza, come principio e fonte del perdono tra gli uomini. L’uno e l’altro aspetto sono integrativi e non si escludono. Nessuno può perdonare spontaneamente senza la grazia di Dio e nessuno può presumere questa grazia senza avere prima perdonato eventuali debitori.
La conclusione di Farinella non poteva che essere, in questo senso, più giusta: le sue ultime parole nel libro riguardano l’eucaristia, vale a dire la comunione, come luogo vitale in cui sperimentare ogni volta in tutta la sua novità liberante e inaudita la direzione, il senso e il cuore pulsante della comunità cristiana: la sua fonte e il suo culmine, che ogni volta dobbiamo reimparare e praticare di nuovo. Non esiste, insomma, una “comunione” o una eucaristia di tipo intimistico e personalistico; non è possibile “fare la comunione” e rimanere chiusi alla dinamica comunitaria.
A ribadire l’errore di una comprensione dei rapporti comunitari di tipo economico, ecco ancora queste parole dell’autore:
Il concetto di peccato appartiene al regime della religione contrattuale, e quindi al rapporto commerciale tra estranei, che per sua natura deve quantificare, regolare, stabilire, riconoscere, permettere, proibire, concedere. […] Se uno ama, non può volere che l’amore e se ama, nulla in lui è fuori dall’amore. Solo in un finto amore mercantile c’è posto per il do ut des, e la parcellizzazione percentuale del 50% appartiene a una logica di prostituzione: uno scambio di favori.
Il tratto fondamentale di queste considerazioni, e anche il loro maggiore problema, è proprio quel “rapporto tra estranei“. Da un lato possiamo dire che esso dipende in gran parte dalla palese ignoranza dei cristiani nei confronti della loro fede e, soprattutto, delle Scritture, che sono la modalità di relazione e di mediazione vivente con il Signore; un’ignoranza teorica e soprattutto pratica riguarda poi sicuramente anche le pratiche della liturgia, che è l’altro modo complementare di relazione con Dio e con il resto degli uomini. Da un altro punto di vista, invece, bisogna pur ricordare che, in qualche modo, l’estraneità e l’alterità di Dio sono positivamente ineliminabili, come l’alterità tra uomo e uomo. Si tratta di un punto che va salvaguardato, per non rischiare di cadere in una semplificazione sentimentale della fede, che spesso diventa anche chiusura intimistica e personale che poco ha a che fare con il cristianesimo. Il rischio è insito anche nella parola “amore”, troppo sfruttata e, quindi, anch’essa banalizzata se non mostra in se stessa anche la fatica dell’alterità, della differenza, della lotta e dell’in-contro. Quest’ultimo tipo di “ignoranza” nei confronti dell’alterità la potremmo chiamare “mistica”: essa non è in contrasto con l’aumento delle conscenze scritturistiche e rituali; anzi, è proprio attraverso tali mediazioni e il loro approfondimento, fatto di sentire e di ragione, di pratiche e di pensiero, che possiamo avvicinarci ad una relazione con Dio e con gli altri che rispetti la loro complessità e la loro differenza – il sacro pare abitare proprio in questo con-tatto, in questo avere il tatto della distanza, lo stile dell’attesa e la non pretesa di com-prendere, di abitare anche il silenzio della non risposta, la fatica delle mediazioni, dei gesti e delle parole.
“Si è data più importanza al peccato che a Dio stesso” – scrive Farinella. È vero, sicuramente. E questo atteggiamento, se da un lato ha motivazioni legate al “controllo” e alla repressione – motivazioni di potere, dall’altro è esso stesso legato al rifiuto di quella fatica delle mediazioni e della conoscenza della propria fede che abbiamo detto sopra. L’immagine di un Dio legalistico e contrattuale, legata al peccato che diventa più importante di Dio stesso, è altrettanto fuorviante di quella di un Dio totalmente familiare e personale, intimistico e immediato. Sono due immagini, entrambe dia-boliche ed errate e spesso, chi critica in maniera unilaterale le mediazioni commette l’errore di identificarle totalmente con le strutture gerarchiche e le istituzioni. Ma così non è, perché le mediazioni ci abitano dal principio, nella nostra stessa struttura antropologica, quella stessa struttura che il Cristo ha abitato e santificato con la sua incarnazione.
* ANDREA PONSO
Andrea Ponso è nato a Noventa Vicentina nel 1975. Si occupa di traduzione di testi biblici dall’ebraico, e poetici dal francese e dall’inglese; di esegesi biblica, teologia e liturgia. Svolge attività di ricerca e di critica, con vari studi apparsi in riviste e convegni, in Italia e all’estero; collabora con il Master di studi interculturali dell’università di Padova e fa parte del comitato scientifico del Monastero di Camaldoli (AR). Come poeta ha pubblicato nelle maggiori antologie della sua generazione. Il suo primo libro, “La casa” con prefazione di Maurizio Cucchi, è del 2003 per Stampa. Dopo altre uscite presso Mondadori (“Nuovissima poesia italiana” e “Almanacco dello Specchio”), è uscito il suo secondo libro in versi, “I ferri del mestiere” presso la collana de Lo Specchio di Mondadori. Attualmente, collabora come editor con alcune case editrici, e sta portando a termine una nuova traduzione dall’ebraico dei libri di Isaia, Qohèlet e Cantico.